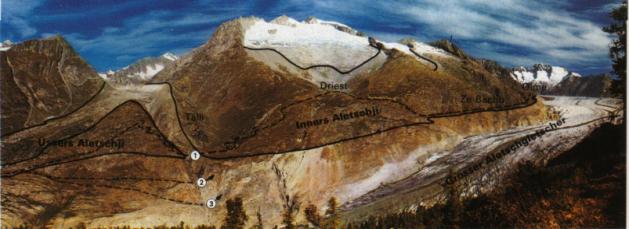7
gita de
L’Escursionista
curioso:
Nel
regno dell’Aletschgletscher
Tra
le gole del Massaweg e Villa Cassel
Domenica
30 settembre 2007
Quest’anno
la gita che proponiamo è molto varia nei suoi contenuti: Blatten è un paesino
di origine Walser, poi c’è il Massaweg che è l’antico percorso di un bisse
(tipico canale di irrigazione – vedere documentazione gita del 2005) ci sono
gli impianti di Riederalp, che con Bettmeralp e Fischeralp formano uno dei
maggiori comprensori sciistici del Vallese, l’importante Villa Cassel con il
suo interessante museo glaciologico e l’annesso giardino botanico situata
all’interno del sito Jungfrau - Aletsch - Bietschhorn
che nel 2001 è stato inserito dall’UNESCO tra i siti di interesse
mondiale e sede della Pro Natura Elvetica,
c’è l’Aletschgletscher,
il più grande ghiacciaio delle Alpi con la sua riserva naturale dell’Aletschwald
o Foresta dell’Aletsch che già
da sola merita una visita ed infine c’è la diga di Gibidum: sembra
impossibile ma fino a metà del milleottocento il ghiacciaio dell’Aletsch
arrivava ipoteticamente a tuffarsi nelle sue verdi e fredde acque.Ipoteticamente
perché la diga è stata costruita in epoca molto più recente. Compagno
costante della gita è un incredibile panorama che varia di volta in volta e che
è uno dei motivi per i quali abbiamo scelto questa gita.
Blatten
 Per
distinguerlo dall’omonimo Blatten situato nella Lötschental solitamente è
scritto Blatten bis Naters. Situato su uno strategico poggio e visibile solo
all’ultimo momento, conserva una parte antica
che merita senz’altro una visita. Lasciando sulla sinistra la stazione
a valle della funivia che sale alle ripide ma bellissime
piste di sci di Belalp, da dove parte il sentiero che in poco più di due
ore porta allo Sparrhorn (altra gita della zona che raccomandiamo) splendido
belvedere sul ghiacciaio dell’Oberaletsch, Blatten è punto di partenza per
numerose traversate verso Riederlap e Bitsch. Belalp è anche una delle naturali
porte di ingresso verso l’Oberland Bernese
che può essere raggiunto grazie alla presenza dell’Oberaletschhutte,
bellissimo rifugio
Per
distinguerlo dall’omonimo Blatten situato nella Lötschental solitamente è
scritto Blatten bis Naters. Situato su uno strategico poggio e visibile solo
all’ultimo momento, conserva una parte antica
che merita senz’altro una visita. Lasciando sulla sinistra la stazione
a valle della funivia che sale alle ripide ma bellissime
piste di sci di Belalp, da dove parte il sentiero che in poco più di due
ore porta allo Sparrhorn (altra gita della zona che raccomandiamo) splendido
belvedere sul ghiacciaio dell’Oberaletsch, Blatten è punto di partenza per
numerose traversate verso Riederlap e Bitsch. Belalp è anche una delle naturali
porte di ingresso verso l’Oberland Bernese
che può essere raggiunto grazie alla presenza dell’Oberaletschhutte,
bellissimo rifugio
L’itinerario
inizia con un primo ma brevissimo tratto di strada asfaltata che abbandoniamo
per inoltrarci in una caratteristica zona umida dove il muschio
e piccoli acquitrini ci accompagneranno fino ad un poggio da cui inizia una
discesa. Un altro breve tratto asfaltato e superiamo un ponte situato alla base della diga di Gibidum. Da qui la strada si
fa sterrata e la seguiamo per un tratto fino ad una casa isolata. Un cancello in
legno segnala l’inizio del Massaweg, ovvero sentiero della Massa. Prende il
nome dal torrente che percorre la valletta e ricalca pressoché fedelmente il
tracciato del Bisse Riederi. Un breve accenno su cosa è un bisse. In tedesco si
chiama Suonen, in francese Bisse: sono dei canali artificiali che servono ancora
oggi a trasportare l’acqua dei ghiacciai verso i prati coltivati più a valle.
A volte sono
delle vere opere di
ingegneria che attraversano pareti scoscese,
Massaweg
Il
Massaweg è stato tra i sentieri più recentemente  del
bisse chiamato Riederi. I primi accenni di questo canale risalgono al 1385 e la
presa d’acqua era situata in località Beim Steg in quel di Rischinen sotto Blatten.
Questo fino al 1824 quando a causa della richiesta sempre maggiore di acqua, gli
abitanti di Ried in accordo con quelli di Naters, costruirono un nuovo bisse con
presa acqua sopra Belalp ed un percorso molto tortuoso che, attraversando la Lüsgenalp,
passa sotto l’Aletschbord per arrivare a Holzji e quindi alla diga di Gibidum.
Nonostante questo nuovo canale durante l’estate del 1935 per ben 16 torridi
giorni non fu possibile irrigare i
campi di Ried. Lungo il sentiero, all’imbocco di una galleria si può
osservare sulla destra il percorso aereo che faceva il tracciato originale del
canale. Vi invito a riflettere sui problemi che dovevano affrontare le persone
destinate alla costruzione ed alla successiva manutenzione di questi canali.
Verso la fine del tratto più caratteristico una cappelletta dedicata alla
Madonna di Lourdes, scavata nella roccia ed un crocifisso, ci testimoniano la
religiosità di coloro che lavoravano alla manutenzione del canale
del
bisse chiamato Riederi. I primi accenni di questo canale risalgono al 1385 e la
presa d’acqua era situata in località Beim Steg in quel di Rischinen sotto Blatten.
Questo fino al 1824 quando a causa della richiesta sempre maggiore di acqua, gli
abitanti di Ried in accordo con quelli di Naters, costruirono un nuovo bisse con
presa acqua sopra Belalp ed un percorso molto tortuoso che, attraversando la Lüsgenalp,
passa sotto l’Aletschbord per arrivare a Holzji e quindi alla diga di Gibidum.
Nonostante questo nuovo canale durante l’estate del 1935 per ben 16 torridi
giorni non fu possibile irrigare i
campi di Ried. Lungo il sentiero, all’imbocco di una galleria si può
osservare sulla destra il percorso aereo che faceva il tracciato originale del
canale. Vi invito a riflettere sui problemi che dovevano affrontare le persone
destinate alla costruzione ed alla successiva manutenzione di questi canali.
Verso la fine del tratto più caratteristico una cappelletta dedicata alla
Madonna di Lourdes, scavata nella roccia ed un crocifisso, ci testimoniano la
religiosità di coloro che lavoravano alla manutenzione del canale Dio
per i pericoli scampati. Più avanti ancora, alcune catene aiutano a superare un
tratto del sentiero particolarmente umido che ad inizio o fine stagione nelle
giornate fredde può presentare qualche problema. Alcuni ponticelli di legno ci
permettono di arrivare ad uno dei posti più caratteristici della gita: qui sono
stati ricostruiti i muri in sasso che una volta sorreggevano i tronchi in legno
nei quali scorreva l’acqua. I tronchi sono stati recentemente sostituiti, ma
uno più datato giace dimenticato sul sentiero pochi metri più avanti. Ormai
siamo quasi fuori dalla valle e ci attendono i verdi prati che precedono le case
di Ried-Morel. Lo sguardo spazia sulla valle Saltina che sale al Passo del
Sempione e sulla città di Briga ed in particolare sulla grande stazione
ferroviaria affiancata dall’ingresso del traforo che collega Italia e
Svizzera. Su tutto scintilla la molte ghiacciata del Fletschorn e più a destra
il Dom sembra essere tuttuno con il Lenzspitze ed il Nadelhorn. Ci attende un
tratto di strada asfaltata che percorreremo fino alla stazione della cabinovia
che ci porterà alle case di Riederalp. Da qui in circa mezzora arriviamo a
Villa Cassel ed al suo museo. In alternativa vi proponiamo la salita in
seggiovia fino a Hohflue (2227 m) da dove lo sguardo spazia sulla distesa
ghiacciata dell’Aletschgletscher, incontrastato re dei ghiacciai delle Alpi
che ci offre una vista mozzafiato: quello che noi vediamo è circa la metà
della sua estensione. Se gli giriamo le spalle ciò che vediamo è una carellata
di punte glaciali dei satelliti del Monte Rosa e dei 4000 vallesani tra i quali
si scorge la triangolare mole del Cervino.
Dio
per i pericoli scampati. Più avanti ancora, alcune catene aiutano a superare un
tratto del sentiero particolarmente umido che ad inizio o fine stagione nelle
giornate fredde può presentare qualche problema. Alcuni ponticelli di legno ci
permettono di arrivare ad uno dei posti più caratteristici della gita: qui sono
stati ricostruiti i muri in sasso che una volta sorreggevano i tronchi in legno
nei quali scorreva l’acqua. I tronchi sono stati recentemente sostituiti, ma
uno più datato giace dimenticato sul sentiero pochi metri più avanti. Ormai
siamo quasi fuori dalla valle e ci attendono i verdi prati che precedono le case
di Ried-Morel. Lo sguardo spazia sulla valle Saltina che sale al Passo del
Sempione e sulla città di Briga ed in particolare sulla grande stazione
ferroviaria affiancata dall’ingresso del traforo che collega Italia e
Svizzera. Su tutto scintilla la molte ghiacciata del Fletschorn e più a destra
il Dom sembra essere tuttuno con il Lenzspitze ed il Nadelhorn. Ci attende un
tratto di strada asfaltata che percorreremo fino alla stazione della cabinovia
che ci porterà alle case di Riederalp. Da qui in circa mezzora arriviamo a
Villa Cassel ed al suo museo. In alternativa vi proponiamo la salita in
seggiovia fino a Hohflue (2227 m) da dove lo sguardo spazia sulla distesa
ghiacciata dell’Aletschgletscher, incontrastato re dei ghiacciai delle Alpi
che ci offre una vista mozzafiato: quello che noi vediamo è circa la metà
della sua estensione. Se gli giriamo le spalle ciò che vediamo è una carellata
di punte glaciali dei satelliti del Monte Rosa e dei 4000 vallesani tra i quali
si scorge la triangolare mole del Cervino.
Villa Cassel
 Il suo stile architettonico
ricorda un po’ le case dell’Alsazia
e la posizione è
certamente
Il suo stile architettonico
ricorda un po’ le case dell’Alsazia
e la posizione è
certamente
Villa Cassel è
situata proprio sul confine della prima riserva naturale delle Alpi curata
dall’UNESCO.
Jungfrau – Aletsch – Bietschhorn
Chi
non conosce il Jungfraujoch, stazione terminale del tanto discusso e costoso
trenino che parte da Grindelwald e passando all’interno dell’Eiger deposita
ogni anno migliaia di turisti e alpinisti a quota 3454 m.? Il termine Alestch fa
venire in mente sia il ghiacciaio sia la montagna più alta della zona, mentre
il Bietschhorn è quella piramide aguzza che si vede scendendo dal Passo del
Sempione la cui via di salita più facile è una cresta di misto con difficoltà
di IV grado. Tra questi tre punti geografici si trova la più vasta area
glaciale protetta del centro – sud Europa.
Si tratta di 54.000 ettari il 77% dei quali si trova in Vallese ed il
restante 23 % nel cantone di Berna. In
questo sterminato territorio ben nove
punte superano i 4000 metri: Jungfrau (4158 m), Monch (4107 m), Gross e Hinter
Fischerhorn (4048 e 4025 m), Lauteraarhorn (4042 m), Schreckhorn (4078 m),
Aletschhorn(4193 m.), Finsteraarhorn (4273 m), Grossgrunhorn (4043 m), mentre
quelle che superano i 3500 m non si contano neppure.
|
___________
Limite del Ghiacciaio verso il 1850 ----------------
Percorsi per raggiungere i pascoli da Ussere Aletschji (Belalp) a Innere
Aletschji attraverso l’Oberaletschgletscher (a sinistra nella foto) 1
durante il periodo di massima espansione del ghiacciaio 2
attorno al 1900 3
verso il 1935/1940
(foto presa nel 1980) |
 Perché
questa zona è stata inserita dall’UNESCO tra le zone di interesse mondiale?
Innanzitutto per le sue caratteristiche paesaggistiche ed estetiche. Si
pensi che il ghiacciaio dell’Aletsch con
la lunghezza di 23 km, la superficie di 128 km quadrati e la profondità di 900
metri registrata nel Konkordiaplatz è
il più esteso delle Alpi. In paragone il più esteso ghiacciaio del Monte
Bianco è lungo “solo” 10 km. La velocità media annua è compresa tra 185
ed i 205 metri registrati nella zona del Konkordiaplatz, mentre all’altezza
della foresta dell’Aletsch la velocità annua è compresa tra i 74 e gli 86
metri (i dati si riferiscono al 1981). Geologicamente parlando è una zona molto
varia dove a punte formate da rocce cristalline sormontate da sedimenti calcarei
(Monch e Jungfrau) si alternano punte prevalentemente
calcaree come l’Eiger. Il ghiacciaio dell’Alestch è stato misurato
fin dal 1892 ed offre una delle più ricche documentazioni sulla storia della
glaciologia delle Alpi. Nella foto la linea continua segnala la massima
estensione del ghiacciaio raggiunta.
Perché
questa zona è stata inserita dall’UNESCO tra le zone di interesse mondiale?
Innanzitutto per le sue caratteristiche paesaggistiche ed estetiche. Si
pensi che il ghiacciaio dell’Aletsch con
la lunghezza di 23 km, la superficie di 128 km quadrati e la profondità di 900
metri registrata nel Konkordiaplatz è
il più esteso delle Alpi. In paragone il più esteso ghiacciaio del Monte
Bianco è lungo “solo” 10 km. La velocità media annua è compresa tra 185
ed i 205 metri registrati nella zona del Konkordiaplatz, mentre all’altezza
della foresta dell’Aletsch la velocità annua è compresa tra i 74 e gli 86
metri (i dati si riferiscono al 1981). Geologicamente parlando è una zona molto
varia dove a punte formate da rocce cristalline sormontate da sedimenti calcarei
(Monch e Jungfrau) si alternano punte prevalentemente
calcaree come l’Eiger. Il ghiacciaio dell’Alestch è stato misurato
fin dal 1892 ed offre una delle più ricche documentazioni sulla storia della
glaciologia delle Alpi. Nella foto la linea continua segnala la massima
estensione del ghiacciaio raggiunta.
All’epoca
il ghiacciaio dell’Oberaletsch confluiva nell’ Aletsch e formavano una unica
colata che arrivava a lambire il posto ove è stata costruita la diga di Gibidum.
Nel suo lento progredire l’Oberaletschgletcher ha scavato delle tortuose gole
che l’uomo ha con il tempo reso praticabili attraverso un sentiero scavato
nella roccia in modo da poter raggiungere preziosi pascoli. A questoo
proposito è da segnalare una
singolare iniziativa che
con il tempo è diventata attrazione turistica. All’inizio
dell’estate le
particolari pecore
del Vallese, (caratterizzate
dal simpatico muso nero e dalle 4 zampe pure nere) vengono condotte in località
Innere Aletschji, dove vengono lasciate pascolare in piena libertà fino
all’ultimo fine settimana di agosto, quando i pastori con una festa che dura
tre giorni vanno a riprenderle per portarle ai diversi ovili. E’ uno
spettacolo vedere questa enorme fiumana (si parla di 2 o 3 mila capi) che lascia
i pascoli per arrivare a Belalp dove viene smistata a seconda del colore del
segno sulla pelliccia. Per la cronaca il venerdì vengono recuperati gli
animali, il sabato arrivano a Belalp e la domenica sono smistate tra un tripudio
di cori alpini e qualche stand dove ai presenti viene offerta una gustosa
“suppe” (anche alle nove di mattina!).
Ritorniamo
sulla storia del ghiacciaio. La prima citazione scritta dell’Aletschgletscher
risale al settembre del 1653 quando gli abitanti di Naters in seguito al
progressivo avanzare del fronte glaciale, vedendo minacciata la possibilità di
raggiungere i pascoli di Innere Aletscji, mentre alcune baite dell’alpeggio
Ussere Aletschji erano già state travolte, chiesero ai preti gesuiti di Sierre
di organizzare una processione per scongiurare il pericolo. Dopo sette giorni di
preparazione, la popolazione preceduta da due preti
si diresse verso il ghiacciaio alternando canti e salmi. Sembra che le
preghiere abbiano ottenuto l’effetto desiderato perché da quel momento il
ghiacciaio rimase tranquillo. Il fatto che il ghiacciaio minacciasse dei pascoli
alpini fa credere che fosse al suo massimo storico.
Il suo
progressivo ritirarsi mise in crisi la richiesta di acqua dei comuni di Naters,
Ried-Morel e Bitsch per cui
ricercarono fonti alternative per l’approvvigionamento dell’acqua.
Pochi anni dopo che Villa Cassel divenne proprietà della Pro Natura Elvetica, fu
stipulato un accordo tra i comuni interessati all’acqua della Riederi secondo
il quale l’associazione naturalistica dava il permesso di costruire una
condotta sotto il Riederhorn, in cambio dell’impegno degli abitanti dei comuni
a non sfruttare le piante dell’Aletschwald
per ricavarne legname. Questo accordo doveva durare 99 anni, ma nel frattempo è
subentrato l’UNESCO ed il bosco di larici, alcuni dei quali raggiungono i 1000
anni, è salvo.
cui
ricercarono fonti alternative per l’approvvigionamento dell’acqua.
Pochi anni dopo che Villa Cassel divenne proprietà della Pro Natura Elvetica, fu
stipulato un accordo tra i comuni interessati all’acqua della Riederi secondo
il quale l’associazione naturalistica dava il permesso di costruire una
condotta sotto il Riederhorn, in cambio dell’impegno degli abitanti dei comuni
a non sfruttare le piante dell’Aletschwald
per ricavarne legname. Questo accordo doveva durare 99 anni, ma nel frattempo è
subentrato l’UNESCO ed il bosco di larici, alcuni dei quali raggiungono i 1000
anni, è salvo.
Il fatto di
essere riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità
non fa di questa zona un territorio dove è difficile fare qualsiasi
intervento umano, anzi tuttaltro. Se finalizzati a miglioramenti turistici o
antropologici, gli interventi si fanno, eccome, ma con precise caratteristiche e
studiate metodologie, quelle che da sempre distinguono il popolo svizzero per la
sua precisione. Un esempio tra tutti è il nuovo sentiero panoramico che da
Belalp in quattro ore e mezza conduce all’Oberaletschhutte: tagliato nella
roccia ed ottenuto anche sparando mine. Il vecchio sentiero era diventato troppo
pericoloso per permettere un tranquillo accesso alla capanna e l’Oberaletschgletscher
negli ultimi anni si è abbassato di circa 5 metri all’anno obbligando il
custode ad aggiungere nuove scale a quelle già esistenti per permettere agli
alpinisti ed agli escursionisti di arrivare alla capanna che, quando è stata
costruita nel 1890, era pochi metri sopra il livello del ghiacciaio.
La
diga di Gibidum
 Lasciamo
a malincuore la Riederfurka e ci avviamo verso una nuova meta: la diga di
Gibidum che in fondo alla valle raccoglie le acque di fusione dei ghiacciai
circostanti.Rapportato al Massaweg, il sentiero diventa stretto e con moltissimi
tornanti. Tra boschi e pascoli si intravedono al di là della valle le rocce
tonde e lisce che una volta erano coperte dall’Aletschgletscher. Ad una radura
vediamo il muro della diga. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1964
e fu messa in servizio dopo tre anni. E’ di tipo a volta e con un’altezza di
122 m., una lunghezza di 3279 m ha la capacità di invaso di 9,2 milioni di m.
Lasciamo
a malincuore la Riederfurka e ci avviamo verso una nuova meta: la diga di
Gibidum che in fondo alla valle raccoglie le acque di fusione dei ghiacciai
circostanti.Rapportato al Massaweg, il sentiero diventa stretto e con moltissimi
tornanti. Tra boschi e pascoli si intravedono al di là della valle le rocce
tonde e lisce che una volta erano coperte dall’Aletschgletscher. Ad una radura
vediamo il muro della diga. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1964
e fu messa in servizio dopo tre anni. E’ di tipo a volta e con un’altezza di
122 m., una lunghezza di 3279 m ha la capacità di invaso di 9,2 milioni di m.
Bibliografia
consultata:
I
ghiacciai delle Alpi,
di Bachmann Robert C. Zanichelli
Editore, Milano, 1980
Ghiacciai
della Svizzera
di Bachmann Robert C. Edizioni Silva, Zurigo, 1983
La
rivista del trekking anno
XVI (1999) n. 1, Piero Amighetti Editore, Sala Baganza (PR)
Le Alpes
Revue du Club Alpin Suisse - Numero special du 125 anniversaire du CAS –
3°
Cahier Trimestral 1988
| Torna home page CAI Varallo |